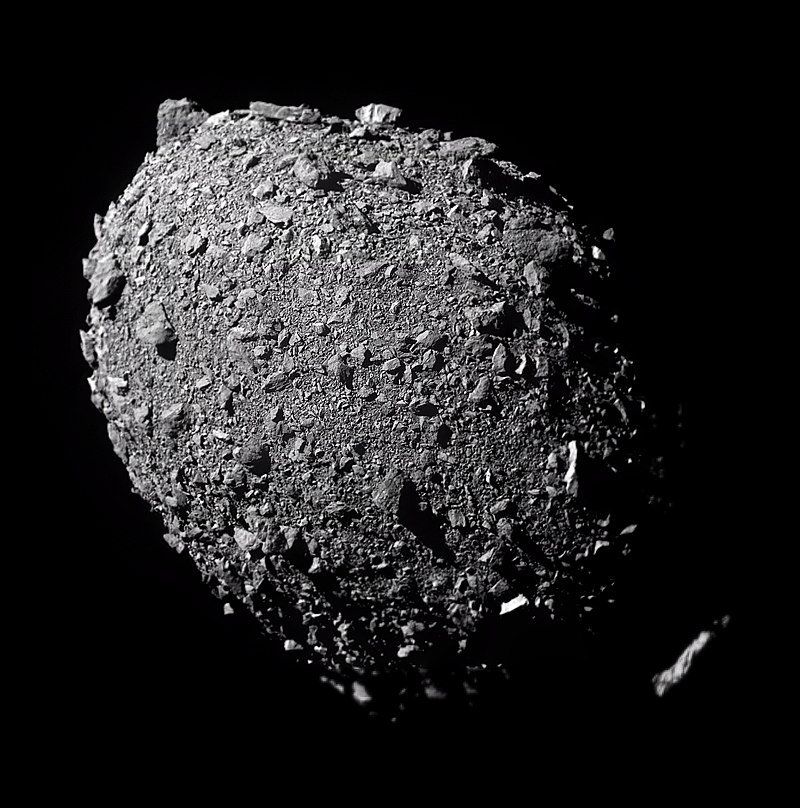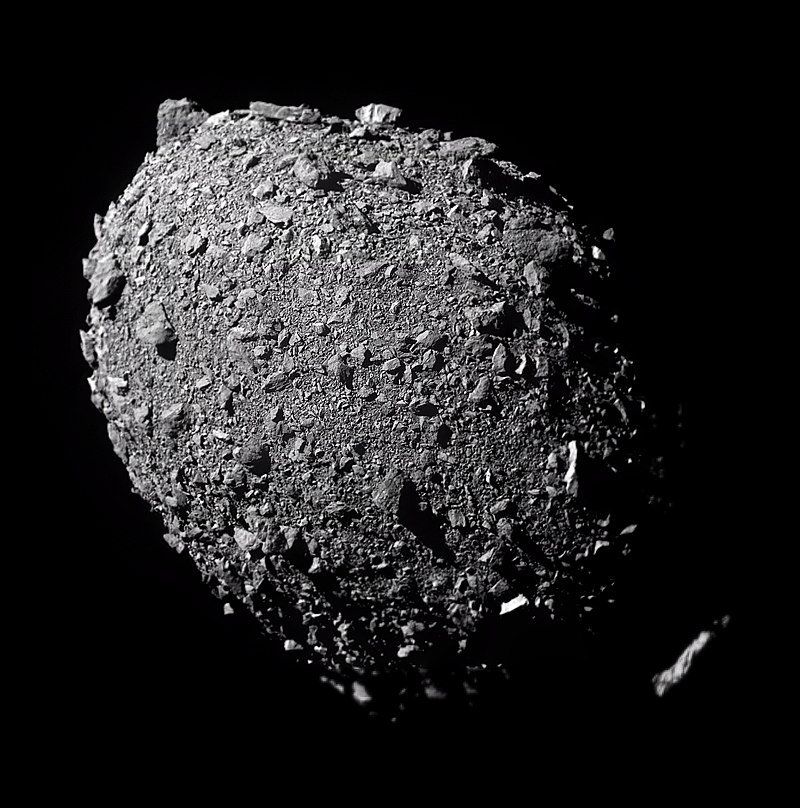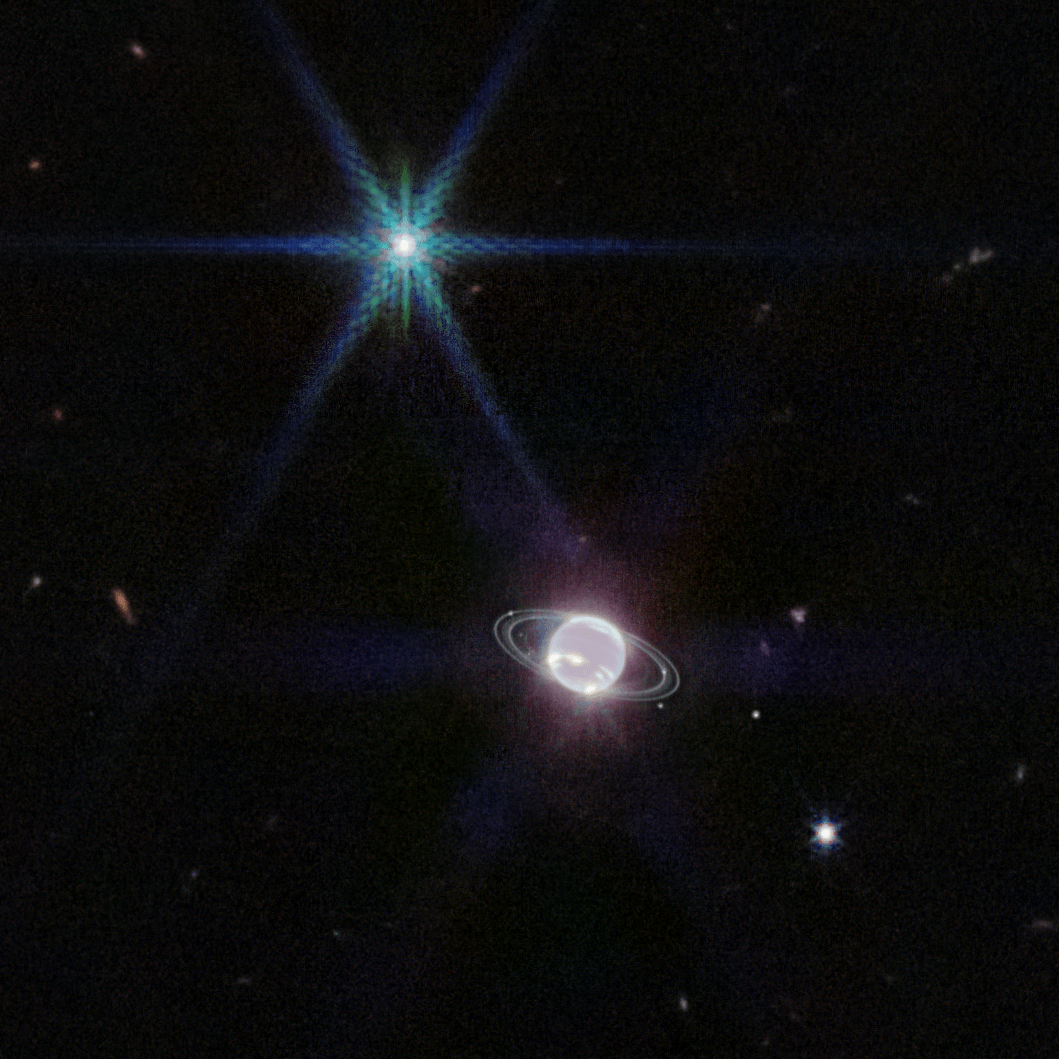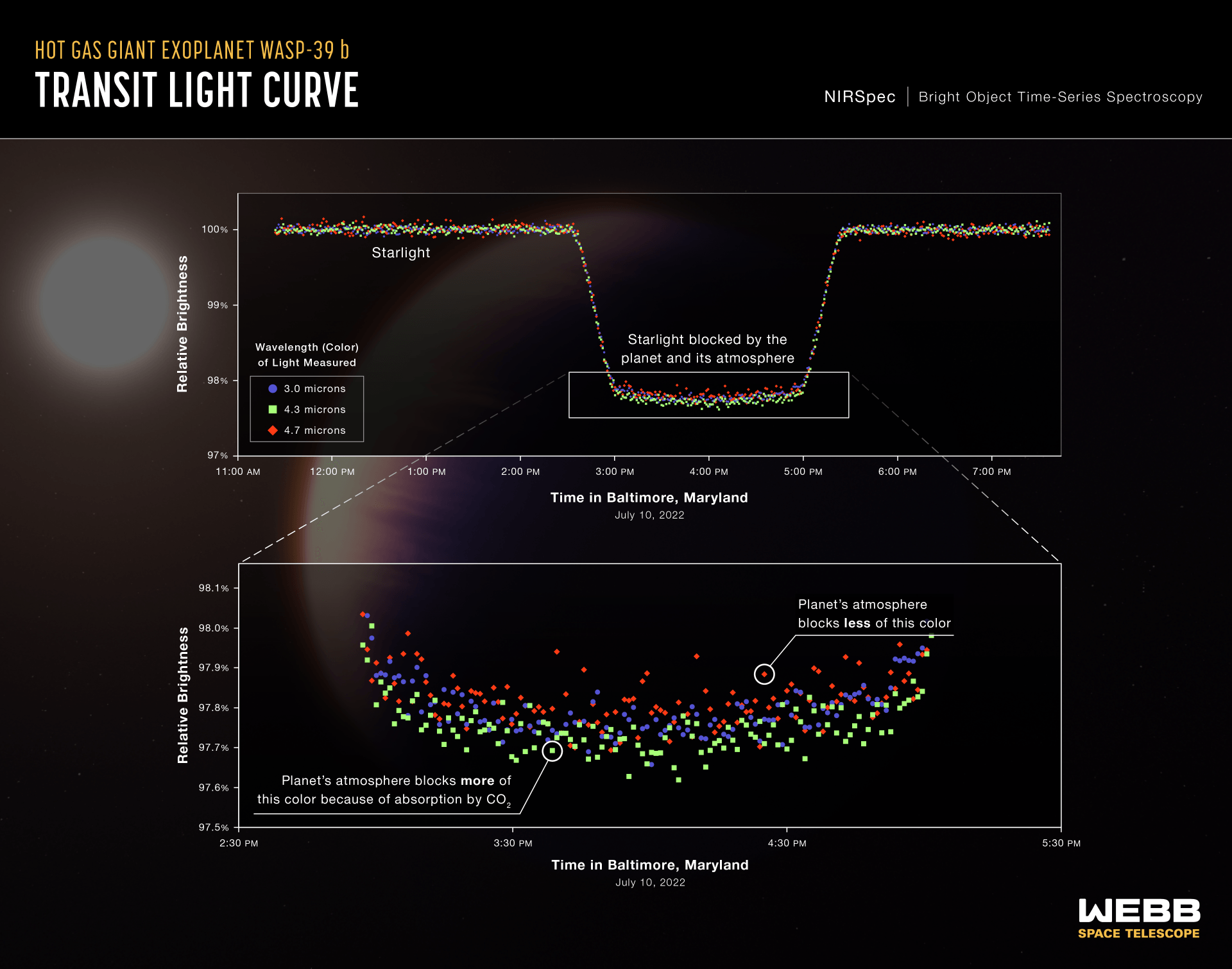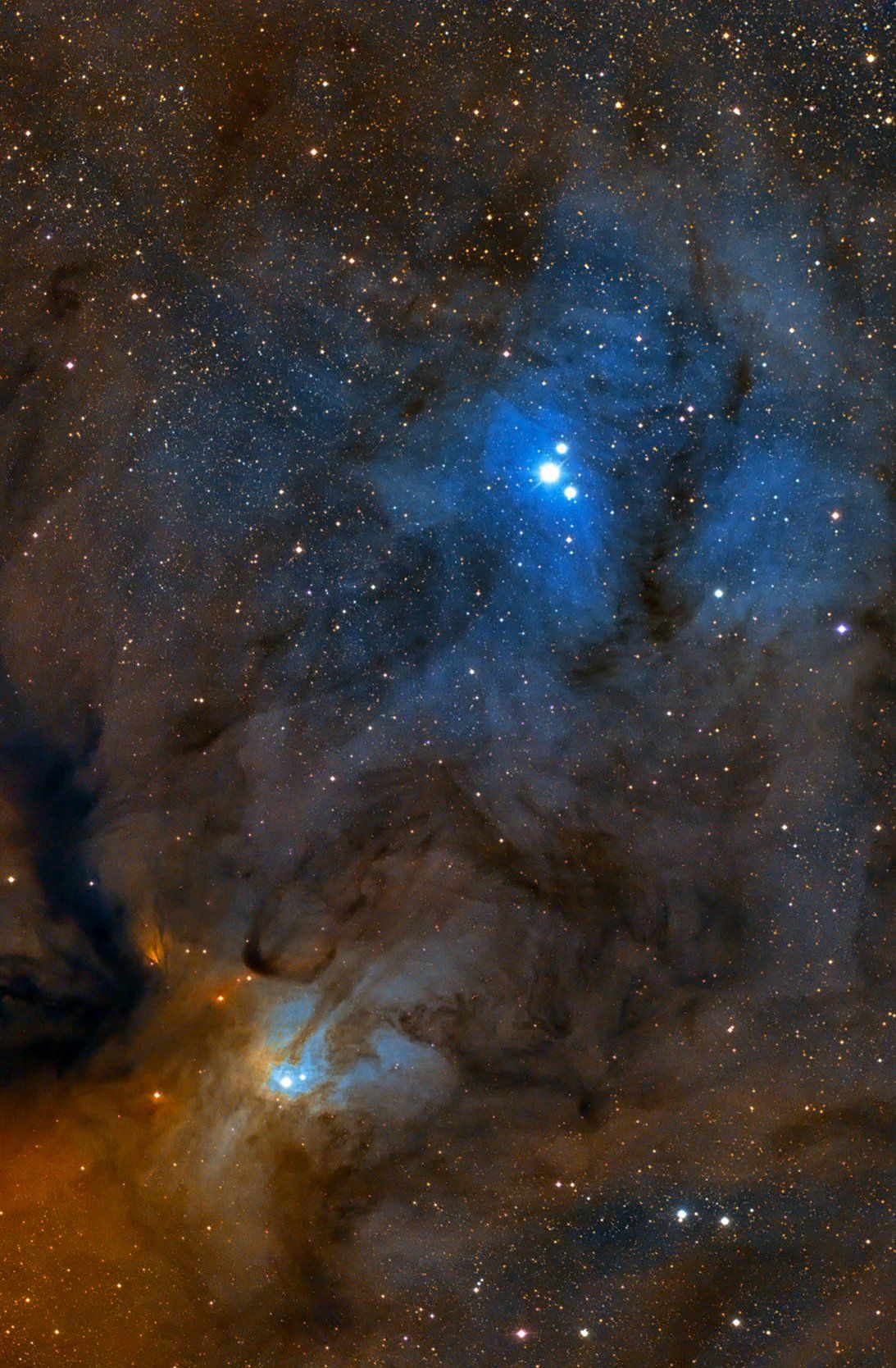SAGITTARIUS A FINALMENTE SVELATO!
SAGITTARIUS A FINALMENTE SVELATO!

Eccolo, finalmente ripreso in una risoluzione come mai prima d’ora, il “mostro” situato al centro della Galassia, celato da nubi di polveri e gas così dense al punto da indurne un’estinzione della sua luminosità di ben 25 magnitudini. A prima vista, assomiglia moltissimo ad una nebulosa planetaria, una sorta di “M57”, potremmo dire. L’immagine non appare perfettamente nitida, ma questo era nelle previsioni, data l’estrema difficoltà di fotografare un ambiente dove il movimento dei gas che circondano il buco nero, prima di precipitarvi dentro, è velocissimo, tanto da produrre immagini differenti nel giro di pochi minuti; e, in molte di queste, lo stesso orizzonte degli eventi di Sgr A* quasi non si vedeva! E’ questa la reale difficoltà che ha costretto il team di Event Horizon Telescope a spendere gli ultimi anni - le prime immagini risalgono al 2019 - per elaborare opportuni algoritmi capaci di mediare centinaia di immagini riprese dal super interferometro, combinando così i dati raccolti dai telescopi creando l'immagine composita oggi presentata al live meeting organizzato dai team di Event Horizon Telescope e National Science Foundation. Di particolare aiuto, questa volta, è stato il South Pole telescope, situato nella base antartica americana di Amundsen-Scott, dalla quale il centro galattico si rende ben visibile.
I risultati del lavoro prodotto da un team di oltre 300 operatori tra astronomi e tecnici vari sono strabilianti: oltre a rilevare il materiale gassoso che precipita sul buco nero spiraleggiandovi attorno, creando alcuni “nodi luminosi” dove le temperature, per attrito, raggiungono trilioni di Kelvin, è stato possibile misurare il diametro del luminoso anello di plasma, con una discrepanza del 5%. E, ad ulteriore conferma della validità della relatività einsteniana, il diametro angolare dell’anello, come misurato da ETH, coincide esattamente con le previsioni indotte dalla teoria di Einstein.
Dopo che Karl Jansky, nel 1933, rilevò la presenza di una intensa sorgente radio stagliata in qualche punto in Sagittarius, ci vollero ancora 21 anni di accurate osservazioni nella banda radio affinché Sgr A*, come venne poi chiamata tale radiosorgente, venisse definitivamente associata al centro galattico. Fu, ad ogni modo, all’inizio degli anni ‘80 del secolo scorso che tale sorgente venne finalmente associata alla presenza di un buco nero. Per indagare sempre più in profondità l’ambiente ad esso circostante e rilevare particolari utili a “far luce” su questo misterioso oggetto, vennero condotte diverse campagne osservative nell’infrarosso, che rilevarono la presenza di nubi di polveri spiraleggianti verso qualcosa che, però, rimaneva ancora nascosto. Studi protratti per sedici anni sui moti delle stelle più vicine a Sgr A* indicarono, nel 2008, tale oggetto avere una massa oltre 4 milioni di volte superiore quella del nostro Sole: era questa la prova, pur indiretta che Sgr A* doveva essere null’altro che un buco nero.
Non uno di quelli supermassicci, ma di tutto rispetto, dal momento in cui il suo raggio di Schwarzschild venne stimato in 12 milioni di chilometri. Anche se la sua massa, molto più piccola rispetto a quella di un buco nero supermassiccio, la bassa luminosità nelle onde radio e di quella delle righe di emissione nell’infrarosso, implicano che la Via Lattea non sia da considerarsi - al momento - una galassia attiva, successive osservazioni condotte ad ampio spettro mostrarono come, nelle immediate vicinanze del buco nero che governa la Galassia, le cose non dovevano erano, poi, tanto tranquille: nel 2015, Sgr A* produsse un brillamento nella banda X superiore di ben 400 volte alla normale emissione in quella zona; a questo evento, nel 2019 seguì un improvviso aumento di luminosità nella banda ottica che portò Sagittarius A a divenire ben 75 volte più brillante.
Nel 2018 venne annunciato che la stella S2, una di quelle vicine a Sgr A*, venne osservata muoversi all’incredibile velocità di 7.650 km/s, ovvero il 2,55% della velocità della luce, raggiungendo la minima distanza da Sgr A* a 120 UA, pari a 18 miliardi di chilometri: stando alla teoria della relatività generale di Einstein, a quella distanza dal buco nero la stella S2 avrebbe dovuto esibire un redishift gravitazionale in aggiunta a quello dovuto alla sua velocità di allontanamento da noi osservatori: cosa che venne, a tutti gli effetti, osservata. Nello stesso anno, l'interferometro GRAVITY e i quattro telescopi del Very Large Telescope (VLT) rilevarono nei pressi di Sgr A* alcune nubi di gas che si muovevano a circa il 30% della velocità della luce, che si resero visibili come tre bagliori luminosi, indotti provengano da interazioni magnetiche nel gas molto caldo in orbita molto vicino al Sgr A*. Nel 2019, infine, una stella lontana 29 mila anni-luce dal Sistema Solare e situata in una regione celeste ben lontana dal centro galattico in Sagittarius, venne notata per muoversi nello spazio alla considerevole velocità di 1.755 km/s; secondo alcune ipotesi, questa potrebbe essere stata proiettata al di fuori della Galassia proprio a seguito di una interazione con SgrA*.
Il nostro buco nero galattico è situato ad soli 25.600 anni-luce dal Sistema Solare; una distanza di gran lunga minore rispetto ai 53 milioni di anni-luce che ci separano dal buco nero supermassiccio di M87, che nel 2019 divenne il primo buco nero ripreso direttamente, con una risoluzione senza precedenti dall’array di radiotelescopi di Event Horizon Telescope. Sembra un paradosso ma, nonostante la vicinanza, le piccole dimensioni di Sgr A* inducono una variabilità dei fenomeni di pochi minuti, rendendone l'imaging molto più impegnativo di quello del ben più distante M87. Mentre il buco nero di M87 è sorgente di un nucleo galattico attivo che lancia un incredibile getto visibile a lunghezze d'onda sia radio che ottiche, Sgr A* non evidenzia alcun getto ed ha una velocità di accrescimento di gran lunga minore rispetto a quella del buco nero di M87. I radiotelescopi di EHT osservano simultaneamente i target individuati a una frequenza di 230 GHz ovvero ad una lunghezza d'onda di 1,3 mm utilizzando la una tecnica interferometrica detta “a base molto lunga” (VLBI nell’acronimo inglese); in tal modo, i telescopi sparsi su tutto il pianeta agiscono come un unico telescopio dal diametro equivalente alle delle dimensioni della Terra, permettendo così di risolvere elementi con una dimensione angolare inferiore a 20 microarcosecondi: una potenza tale da poter osservare distintamente un'arancia sulla superficie della Luna!
A differenza della presentazione che vi fu nel 2019 per il buco nero di M87, dove l'emozione a vedere quello straordinario zoom che dalle costellazioni visibili nel cielo primaverile centrava la grande galassia ellittica, addentrandosi sempre più nel suo misterioso nucleo fino a mostrare il BH di M87, questa volta non vi è stato alcuno "zoom" su SgrA* e la sua immagine è comparsa all'improvviso; ma poco importa: il risultato è stato ottenuto.
Come prossimo step, il team di EHT spera di integrare ulteriori radiotelescopi sparsi in tutto il mondo per fornire una visione ancor più dettagliata dei buchi neri M87 e Sgr A*, gli unici due che, al momento, restano accessibili alle potenzialità risolutive degli interferometri. Gli sforzi per vedere ulteriori ulteriori buchi neri richiedono più telescopi con hardware ancora più raffinato e possibilmente il collegamento di un radiotelescopio spaziale a telescopi terrestri.
Image credits: EHT Collaboration
Link alla registrsazione: https://youtu.be/4Ws0iPDSqI4